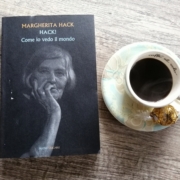E tu, rifaresti la stessa scuola?
Io dico: buone notizie. Lo dico con cognizione, dovendomi ricredere, persino. Lo dico, soprattutto, con il cuore prudente di mamma di un ragazzino di 13 anni che proprio in questi mesi è impegnato in una prima e importantissima scelta: quella della scuola superiore.
Alzi la mano chi non cambierebbe il suo percorso scolastico, potendo tornare indietro. Io, la alzo per prima. Ripenso alla tredicenne che sono stata e ai percorsi di orientamento che era possibile seguire nel 1989: i professori tuonavano le loro sentenze e spesso erano lacrime. Ricordo compagni di classe molto promettenti non essere giudicati all’altezza di un liceo. Scientifico? Sguardo accigliato. Classico? Opzione quasi innominabile. Gli studenti considerati intelligenti erano solo quelli brillanti in matematica. Le attitudini artistiche, un inutile vezzo. La predisposizione musicale, un virtuosismo per pochi. Pedagogia, psicologia, sociologia erano territori leziosi, non contemplati dai licei e lasciati alla certosina pazienza delle maestre che sarebbero uscite dalle Magistrali. Oggi si chiamano Liceo delle Scienze Umane, un’opzione di studio superiore che è riuscita nel tempo ad ammantarsi del rispetto che merita. Qualche retaggio resta: il latino, il greco, la matematica sono ancora oggi considerati potentemente formanti per lo sforzo ragionativo che implicano. Come se dedicarsi allo studio di una lingua viva non avesse un potere immersivo tra gli strati più profondi delle meningi. Come se la programmazione informatica fosse una partita ai videogame incapace di incidere sulla nostra forma mentis.
Ai miei tempi, non lo davano neanche questo semplice libretto, chiaro e completo, con le materie ben elencate, istituto per istituto. Lì dentro ci sono tutte le scelte possibili e il perimetro squadrato di quelle pagine, in qualche modo, conforta.
Si andava per sentito dire. In base al percorso, ai timori o alle aspirazioni dei genitori. Così – ed eccomi qui – ti ritrovavi al classico credendo – errore! – di esserti lasciata alle spalle l’algebra o di poterti dedicare alla letteratura, la tua fidata zona di comfort o magari anche – azzardi persino, nei tuoi più impavidi pensieri – alla scrittura. Macché, la narrativa è proprio un’altra cosa, a scuola, e sa di antologia o di libri sorbiti a forza tra i titoli appioppati per le vacanze estive. Persino nelle facoltà di Lettere, che scelsi poi, la scrittura narrativa era un territorio inesplorato, una cosa troppo “americana” per noi.
Certo, la riforma Gentile che già nel 1923 aveva suddiviso i destini degli scolari tra i percorsi professionalizzanti, gli istituti tecnici e gli elitari licei, fa sentire ancora oggi il suo peso. Dal liceo arriva anche adesso un’eco sofferta, fatte di gobbe leopardiane chine sopra sudatissime scrivanie.
E poi c’è il nuovo smalto delle scuole tecniche: loro, la risposta a quel mercato del lavoro così insoddisfatto, i bisogni delle imprese in eterna sete di lavoratori pronti all’uso, come se la scuola non fosse il luogo della prima impostazione, della cassetta degli attrezzi, come se quel benedetto diplomino potesse essere già sporco di grasso come le mani di un meccanico. Come se i giovani non avessero bisogno di un anziano, appena varcata la soglia del nuovo posto di lavoro. Di una guida, un mentore; di ore di pratica, di errori collezionati sperimentando come necessario prezzo del diventare bravi in qualcosa. Così anche il liceo corre ai ripari e si professionalizza. Lo “scollamento” tra scuola e mondo del lavoro non lo vogliamo, no. Lo scientifico ci prova e diventa allora anche Liceo Scientifico dello Sport, o Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.
E ancora: Liceo Scientifico del Made in Italy. Chi vuole, abbandona il latino per entrare nel laboratorio di chimica, o studia una lingua in più per relazionarsi con i turisti di domani, innamorati del brand “Italia”. Di cui andiamo orgogliosissimi. Roba che ci potremmo vivere di solo turismo, noi. E invece… macché. Sempre allo Scientifico, ci sono le “curve sanitarie” per chi già si orienta verso la medicina, la fisioterapia, le scienze infermieristiche. Invitiamo i ragazzi a mettere un piede nella Sanità che li attende. Che il cuore li assista!
Al classico, la lingua straniera non si sacrifica più dopo il biennio perché abbiamo capito che sì, le lingue che si parlano nel mondo sono importanti quanto l’aoristo. Amen.
Poi ci sono gli ITE, gli Istituti Tecnico Economici – e non chiamateli più Ragioneria, boomer che altro non siete! Ah, loro sì: il compromesso più brillante tra istituto tecnico e liceo, con un occhio già strizzato al marketing e alla finanza, che se le guardi bene, le nuove scuole superiori italiane, hanno già il pavoneggiante profumo dell’università.
Scegliere, specializzarsi, idee chiare, ragazzi, idee chiare: non possiamo permetterci di stare su pagine di nessuna utilità. Senso pratico, signori, tutto il resto è hobby. Improduttivo, monetariamente infruttuoso.
Ed eccoli, allora, gli istituti tecnici mentre fanno il loro ingresso trionfale nella super guida che tutto mette in luce.
L’Alberghiero, per esempio, che non forma più – guai ai voi – gli chef o i camerieri di domani, ma la scuola che ha fatto anche lui: Carlo Cracco. Attimi di religioso silenzio ed è subito Masterchef e il sogno di dirigere un ristorante in una Galleria Vittorio Emanuele illuminata da mille stelle Michelin… Ah, il potere racconterino dei media!
Loro, insomma, gli istituti tecnici, l’orgoglio di poter dire: i nostri studenti sono corteggiati dagli imprenditori già dal penultimo anno. E come dar loro torto! Tra questi, ci sono gli ISIS, gli ex ITIS, che noi liceali guardavamo dall’alto al basso, con la spocchia di vezzose educande. Le aule come officine, a scuola con la tuta. Ma anche edifici nei quali entra la tecnologia del nostro oggi e dai quali esci comprendendo l’algoritmo del futuro. Impressionano le loro aule di informatica, i computer in fila come una centrale di controllo con tutte quelle teste di diplomandi che danno sfoggio di sé agli Open Day come batterie di umani pronti a pigiare i pulsanti della Nasa. Mio figlio vuole entrare qui, non ne vuole sapere di liceo. Prende voti alti in matematica – tutto la mamma, ehm… – fa disegni tecnici che non mi capacito di come possano uscire da quelle mani non ancora adulte e sventola il suo patentino ICDL come fosse il distintivo di una temutissima banda di hacker. E del resto, sulle pagine di letteratura, nulla, non si avvertono pulsazioni, i temi sono per lui una tortura di forzata introspezione e lo studio dell’arte non sposta nemmeno un granello della montagna che freme nel masticare di intelligenza artificiale. Scuola tecnica è il consiglio unanime dei suoi professori. Come se non ci fosse tutto il resto della vita per scoprire passioni e scovar anfratti per nuovi stupori.
“Mamma, ma devo fare ancora italiano per altri 5 anni?”
“Sì, figlio mio: non puoi saltare in un balzello dalla terza media al Politecnico!”
È una scelta difficile e tu che sei un genitore, ma anche un tifoso e un coach e una mamma e un papà che vorrebbe condividere i frutti della propria esperienza, a volte maturati a caro prezzo, non puoi far altro che stare alla finestra e veder crescere, con i suoi tempi, quella fragile e verdissima pianticella che si flette al primo soffio di vento. Ma che forse, un giorno, diverrà quercia. Buone notizie, perciò.